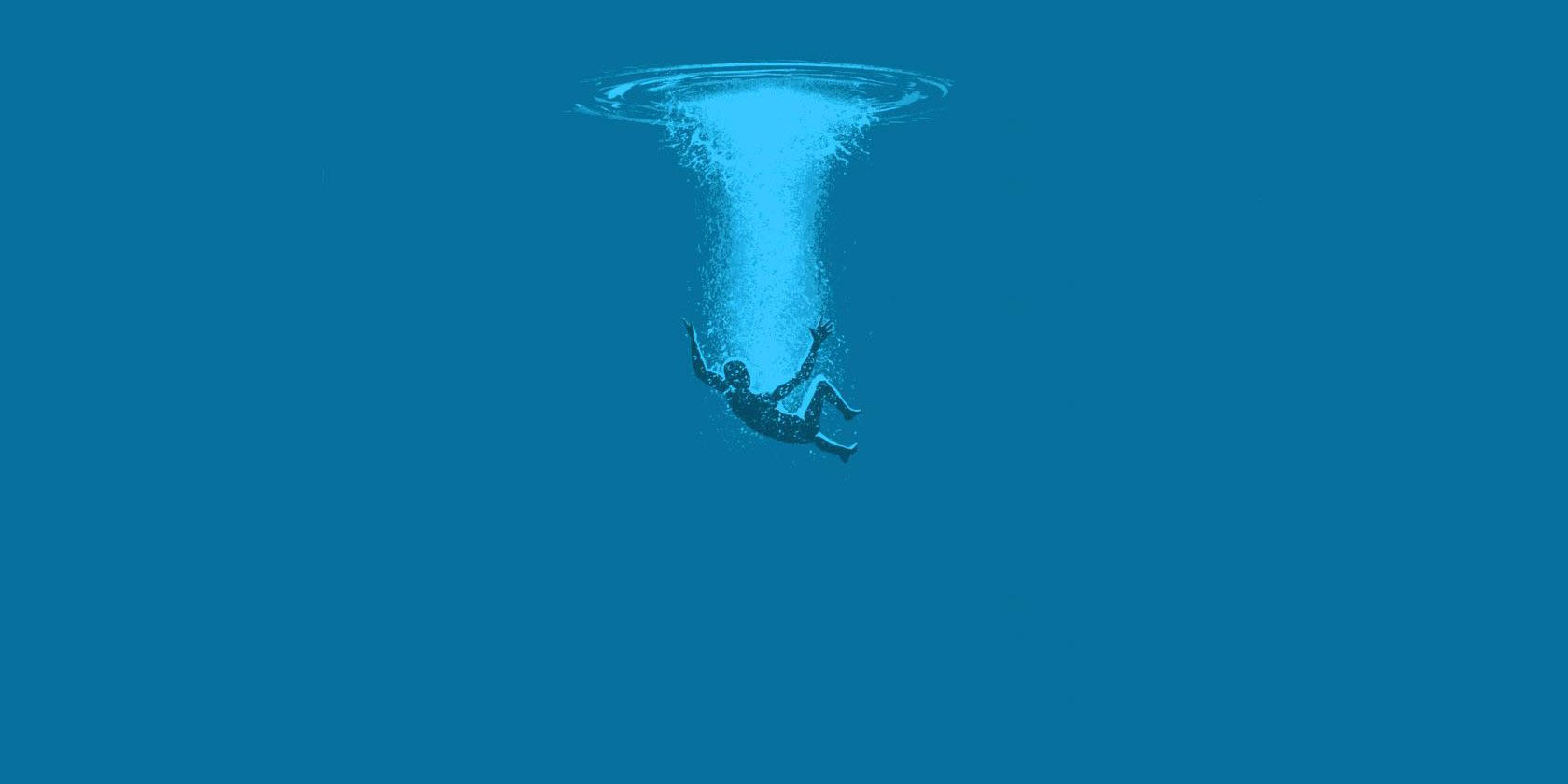di A. Scopenhauer.
§ 71 Il concetto di «nulla»
- A quanto detto sopra si potrebbe ipotizzare un’obiezione: una volta che la nostra trattazione è giunta infine a farci vedere nella perfetta santità la negazione e l’abbandono di ogni volere, e proprio per questo la redenzione di un mondo la cui intera esistenza ci si è presentata come sofferenza, ebbene, non è che proprio questo ci appare come un passaggio nel puro nulla?
- Qui debbo anzitutto osservare che il concetto di nulla è un concetto essenzialmente relativo e si riferisce sempre solo a un che di determinato che esso nega.
- Questa caratteristica è stata attribuita solo al nihil privativum (Kant) che viene contrassegnato con il segno meno in contrapposizione al segno più, un segno meno che, con un rovesciamento del punto di vista, poteva diventare un più; e, in contrapposizione al nihil privativum, è stato posto un nihil negativum, che fosse il nulla sotto ogni rispetto, come esempio del quale si usa la contraddizione logica che toglie sé medesima.
- Considerando la questione più da vicino, un nulla assoluto, un nihil negativum vero e proprio, non lo si può neanche pensare; invece ogni nulla di questo genere, se lo si considera da un punto di vista più elevato o lo si sussume sotto un concetto più ampio, si riduce sempre solo a un nihil privativum.
- Ciascun nulla è pensato come tale solo in relazione a qualcosa d’altro e presuppone questa relazione, e dunque questo qualcosa d’altro. La stessa contraddizione logica non è che un nulla relativo. Non è affatto un pensiero razionale, ma non per questo è un nulla assoluto. La contraddizione logica non è altro che una combinazione di parole, un esempio del non-pensabile, di cui nella logica si ha necessariamente bisogno per provare le leggi del pensiero; perciò, quando a questo scopo si ricorre a un esempio di questo genere, si concentra l’attenzione sull’assurdo, come il positivo di cui si va alla ricerca, e si trascura invece come negativo ciò che ha senso.
- Cos’ dunque ogni nihil negativum, o Nulla assoluto, se viene subordinato a un concetto più elevato, apparirà sempre come un nihil privativum, o Nulla relativo, il quale può sempre scambiare il proprio segno con ciò che nega, di modo che quest’ultimo possa essere pensato come negazione, ed esso stesso, al contrario, come posizione.
- Ciò che è universalmente assunto come positivo, che è ciò che noi chiamiamo l’essente e la cui negazione è espressa nel suo significato più universale dal concetto di nulla, è appunto il mondo della rappresentazione che è l’oggettità della volontà, il suo specchio.
- Questa volontà e questo mondo siamo poi anche noi stessi, e a essi appartiene, come uno dei suoi lati, la rappresentazione in generale: le forme di questa rappresentazione sono lo spazio e il tempo, sì che tutto ciò che da questo punto di vista è essente deve trovarsi in qualche luogo e in qualche tempo.
- Alla rappresentazione appartengono poi anche il concetto, il materiale della filosofia, e infine la parola, il contrassegno del concetto.
- La negazione, la soppressione, il rovesciamento della volontà sono anche la soppressione e la scomparsa del mondo, che ne è lo specchio. Non vedendola più riflessa in questo specchio, ci chiediamo invano dove si sia rivolta, e ci lamentiamo come se, dato che essa non ha più un dove e un quando, fosse svanita nel nulla.
- Un punto di vista rovesciato, se fosse possibile per noi assumerlo, opererebbe un rovesciamento dei segni, e mostrerebbe che quello che noi consideriamo essente è nulla, e che quel nulla è essente. Sino a quando però noi stessi siamo la volontà di vivere, lo possiamo riconoscere e indicare solo negativamente, poiché l’antico principio di Empedocle, secondo il quale il simile può essere riconosciuto solo con il simile, ci preclude qui del tutto ogni possibilità di conoscenza, come pure, al contrario, proprio su di esso si basa in ultima analisi la possibilità di tutta la nostra conoscenza reale, vale a dire il mondo come rappresentazione, o l’oggettità della volontà. Poiché il mondo è l’auto-riconoscersi della volontà.
- Ove tuttavia si continuasse a ogni costo a pretendere di ottenere, in un modo o nell’altro, una conoscenza positiva di ciò che la filosofia può esprimere solo negativamente, come negazione della volontà, non ci resterebbe altro che rinviare alla condizione della quale ebbero esperienza tutti coloro che sono giunti sino alla completa negazione della volontà, e che è stata designata con i nomi di estasi, rapimento, illuminazione, unione con Dio, e così via; una condizione che però non si può chiamare in senso proprio conoscenza, poiché non ha più la forma del soggetto e dell’oggetto e, per di più, è raggiungibile solo nella propria esperienza personale e non può essere comunicata.
Il punto di vista della filosofia
- Ma noi, che ci atteniamo in tutto e per tutto al punto di vista della filosofia, dobbiamo qui accontentarci della conoscenza negativa, soddisfatti di aver raggiunto il confine estremo di quella positiva.
- Abbiamo dunque riconosciuto nella volontà l’essenza in sé del mondo, e in tutte le manifestazioni fenomeniche di quest’ultimo unicamente la sua oggettità; e quest’ultima l’abbiamo inseguita dall’impulso inconsapevole delle più oscure forze naturali sino alle più consapevoli azioni dell’uomo; così non intendiamo in alcun modo sottrarci alla conseguenza che con la libera negazione, con la soppressione della volontà, vengono soppressi anche tutte quelle manifestazioni fenomeniche, quel perenne impulso e quel continuo sforzo senza scopo e senza tregua, a tutti i livelli dell’oggettità, in cui e grazie a cui il mondo consiste, viene soppressa la varietà delle forme che si succedono gradualmente, viene soppresso insieme alla volontà l’intero suo fenomeno, e infine vengono soppresse anche le forme universali di quest’ultimo, tempo e spazio, e anche la sua forma fondamentale, il soggetto e l’oggetto. Nessuna volontà: nessuna rappresentazione, nessun mondo.
- Dinnanzi a noi resta dunque solo il nulla. Ma ciò che si ribella di fronte a questo dissolversi nel Nulla, la nostra natura, è appunto esso stesso solo la volontà di vivere che noi stessi siamo, così come essa è il nostro mondo.
- Il fatto che noi detestiamo così visceralmente il nulla, altro non è che una diversa espressione del fatto che vogliamo così intensamente la vita, che non siamo altro che questa volontà, e che non conosciamo nient’altro che lei.
- Ma se rivolgiamo lo sguardo dalla condizione di indigenza e di parzialità che ci è propria a coloro i quali hanno superato il mondo, nei quali la volontà, conseguita la piena conoscenza di sé, ha ritrovato se stessa in tutte le cose e quindi ha liberamente negato se stessa, e i quali, perciò, attendono di veder scomparire ancora, con il corpo, solo l’ultima traccia di essa, che ancora li tiene in vita; allora ci si mostrerà, in luogo dell’impulso e dello sforzo incessanti, in luogo del continuo passaggio dal desiderio al timore e dalla gioia alla sofferenza, in luogo della speranza che non può mai essere soddisfatta e mai essere estinta, in cui consiste il sogno della vita dell’uomo che vuole, quella pace che è più alta di qualsiasi ragione, quella calma piatta dell’animo, quella quiete profonda, quella fiducia e quella serenità imperturbabili il cui semplice riflesso sul volto, come lo hanno raffigurato i grandi Raffaello e Correggio, è da solo un completo e sicuro Vangelo: solo la conoscenza è rimasta, la volontà è scomparsa.
- Ma noi guardiamo con profonda e dolorosa nostalgia a quello stato vicino al quale la miseria e la disperazione della nostra condizione appaiono, per contrasto, in piena luce. E tuttavia quella contemplazione è la sola che ci possa dare una consolazione durevole, una volta che noi da una parte abbiamo riconosciuto che alla manifestazione fenomenica della volontà, al mondo, appartengono essenzialmente una sofferenza incurabile e una miseria senza fine, e dall’altra vediamo che, con la soppressione della volontà, anche il mondo si dissolve e che dinnanzi a noi non resta che la vuotezza del Nulla.
- In questo modo, dunque, attraverso la considerazione della vita e della condotta dei santi – nei quali, purtroppo, raramente è concesso di imbatterci direttamente, ma che ci sono condotti dinanzi agli occhi dalla storia che di essi ci viene raccontata e, con l’impronta di una verità più profonda, dall’arte -, dobbiamo scacciare la tetra impressione di quel Nulla che si profila come la meta finale alle spalle di ogni virtù e di ogni santità, e che noi temiamo come i bambini che hanno paura del buio, invece di avvolgerlo, come fanno gli Indiani, di miti e di parole senza senso. Noi piuttosto lo ammettiamo apertamente: quello che rimane dopo la completa soppressione della volontà è, per tutti coloro che sono ancora pieni di volontà, senza dubbio il nulla. Ma, al contrario, per coloro nei quali la volontà si è rivolta contro se stessa e ha negato se stessa, è questo nostro mondo così reale, con tutti i suoi soli e le sue vie lattee, a essere nulla.
ARTHUR SCHOPENHAUER
«Il mondo come volontà e rappresentazione»
(prima edizione 1819 – terza ed. 1859)